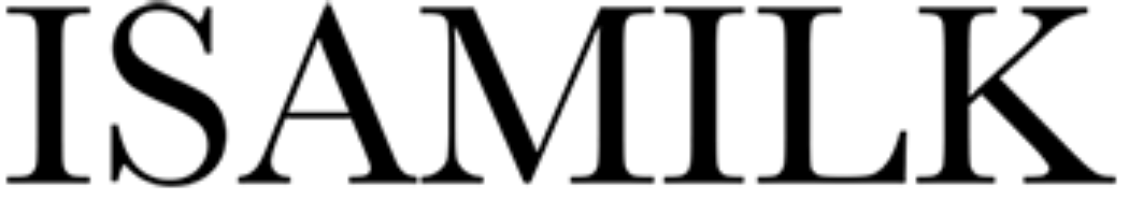di Anna Madia
A quanto pare, si può vivere venticinque anni prima di conoscere il peperone crusco. Prima di scoprire l’alternativa lucana alla patatina, un piccolo corno color rosso fuoco, croccante, leggero come l’aria e buono da volerne ancora.
Andrà più o meno così: ti siederai al ristorante a fianco di una famiglia chiassosa e felice (tutte le famiglie felici si assomigliano tra loro), prenderai tra le mani un pezzo di focaccia ancora calda e guarderai la cartina della Basilicata che, rivestita di plastica e fierezza, riempie una parete intera. Poi si avvicinerà il padrone, uomo di cinquantadue anni e cuoco da trenta, che ti dirà che non è possibile non sapere cosa sia il peperone crusco. Pronuncerà crusch-co, non crusco.
Quanto è bello mangiare l’Italia. Ha il sapore dei paesini che la riempiono, molto più pesanti di una manciata di grandi città. Il bambino a fianco, due occhi azzurri e un biondo caschetto, vuole sedersi al nostro tavolo. Forse ascolta anche lui la descrizione delle fotografie appese alle pareti, della madre sulla strada di casa, delle grandi bestie e degli uomini al lavoro. Mentre il racconto si fa dettagliato e qualche ricordo schizza come olio, la cameriera prende le ordinazioni e io, come sempre, fatico a scegliere. Fuori c’è il Pigneto, quella Roma che non è il centro e non è nemmeno una bellezza ma è piena di storie di quartiere nelle sue vene brulicanti di macchine.
Quanto è bello mangiare Roma. Le strade vicino alla città universitaria sono come i peperoni lucani essiccati e fritti: hanno dentro il sapore del sud. Una crotonese canta le sue vocali troppo aperte, due ragazzi pugliesi strappano un numero di telefono. Stanno cercando una casa con due stanze da letto, di quelle che erroneamente gli annunci definiscono bilocali. Qualche metro indietro c’è Maria, l’amica calabrese che ci voleva per sentirsi a casa. Sempre fedele allo stesso palazzo, ci ha separate solo Lione. Due passi avanti si incontrano i siciliani di Mizzica che, grazie ai loro cannoli, riempiono il marciapiede e gli stomaci dei passanti. Piazza Bologna, in un giorno qualsiasi, sembra la capitale del Sud Italia. Per i romani non esiste, forse non è neanche Roma. Ma per i fuorisede è una culla, la serata durante la settimana, una panchina e una Menabrea.
Tra venerdì e sabato ci muoviamo come cavallette da un lato all’altro della città. Attraversiamo Villa Pamphilj e “Ti ricordi quel primo maggio?” è la frase di rito. Me lo ricordo, sì, e mi ricordo la frittata di pasta che, dopo tutto il resto, serviva per sgrassare. Poi la strada a piedi, come piace a me, e camminando su Via Gregorio VII era arrivata improvvisamente l’estate. L’abbiamo salutata con un gelato della pasticceria siciliana, quello con cui i bambini, seduti sul marciapiede, si dipingono sempre il naso. Anche il cioccolato è un’arte.
Ora è un’altra Roma, un’altra domenica: l’ultima prima dell’autunno. Passo il pomeriggio in macchina guardando fuori dal finestrino e sento che le giornate si stanno lentamente assottigliando. A Pietralata si trovano quei palazzoni che, nell’immaginario collettivo, sono le case dei quartieri popolari. Grigi o marroni, a volte scrostati, sempre corpulenti: non è l’immaginario, sono proprio così. Nella stradina dove sono finita penso bellissima Roma, sì, ma qui non passano nemmeno gli autobus, mancano le fognature, e la notte, la notte cos’è? La notte è buio.
Me lo conferma un vecchietto seduto al tavolo del piccolo parco di quartiere, uno di quei parchi che andrebbero benedetti perché, se non ci fossero, ci sarebbero solo tante piccole case sole come atomi. La domenica di questo signore è un mazzo di carte, quattro chiacchiere e la sigaretta che a ottant’anni è il caso di concedersi senza il proposito di smettere. La mia domenica, invece, prosegue con un altro giro, sulla Prenestina. Poi un caffè e qualche assaggio della fetta di torta che non ho preso ma che avrei dovuto prendere. Pere e visciole sono una gran bella coppia.
Mentre la sbriciolata gioca a rimbalzare su un piatto non mio, all’Eur si sta facendo sera. L’ultimo sole si muove lento sugli spazi enormi di un’utopia urbanistica. Chissà come sarebbero cambiate le città se il fascismo fosse durato di più, si chiede la voce al volante. Chissà, rispondo io. E penso che sia quasi una beffa della storia, pura archeologia, tutto quel razionalismo in una città come Roma. Perché bastano due minuti di cammino per tornare alle vie incastrate male, alle attese eterne degli autobus, alle code che avvelenano il sangue e un po’ rovinano la vita.
Forse questa città va bene solo tra i venti e i trent’anni. Dopo che sei diventato grande e prima di mettere al mondo qualcuno. Come ha detto una volta l’amico che mi ha sempre fatto sorridere, voglio crescere i bambini vicino alle mie colline, in un piccolo paese, con la palla tra i piedi. Mi torna in mente Pietralata, quel parchetto in mezzo al nulla, le fognature che mancano, le cartacce che restano, i palazzoni che ti circondano e le tettoie di Eternit, di cui sto scrivendo, che questa Italia non ha ancora smaltito. Penso che abbia ragione lui, ci vorrebbero più colline e olivi: insegnano i colori, gli odori, i gusti e lasciano la voglia di immaginare che dietro la collina è il sole. Poi, un giorno, perché è tutto una ruota, ci sentiremo dire anche noi: “Voglio andare a studiare a Roma”.
Facebook: Marcia-in-tandem
Twitter: annina_mad
Blog: annamadia.wordpress.com